agli incroci dei venti: graffiti
|
La guerra raccontata, sulla “pellicola filmica” di marmo de la colonna Traiana di Luigi Impieri |
Come far conoscere
al pubblico le conquiste che gli Imperatori romani si preparavano a
compiere ai danni di altre popolazioni, in un’epoca in cui grandi e
potenti tecnologici mezzi di comunicazione di massa, non esistevano?
Come ammaliare la società dell’epoca o meglio sbalordirla, come diremmo
oggi, con effetti speciali e convincerla in merito alla “bontà” delle
spedizioni di conquista, della potente macchina militare, di Roma
Imperiale?
Erano queste, possiamo immaginarle, domande ricorrenti, a cui il potere
politico e militare romano anche nel I sec. dC. cercava di darsi
risposta.
In un'epoca in cui, a differenza di oggi, non c’era nessuna forma rapida
di comunicazione propagandistica in grado di arrivare velocemente nelle
case di tutta la gente; bisognava trovare una strategia affinché quelle
importanti conquiste potessero essere trasmesse non solo al popolo del
tempo, ma anche ai posteri.
Unico mezzo cui affidarsi dunque, era l’opera d’arte, come forma di
comunicazione di massa.
Gli artisti diversamente dagli scrittori, potevano, infatti, essere in
grado di trasmettere informazioni a tutti, colti e analfabeti,
utilizzando un linguaggio più rapido, quello delle immagini.
Certo, essi dovevano mettersi in posizione di sudditanza rispetto al
sistema politico, ma d’altra parte non troppo diversamente, rispetto a
ciò che oggi sempre più spesso accade col giornalismo nostrano (vedans
le ultime dichiarazioni in proposito del nostro Presidente, Ciampi).
Ma la subordinazione degli artisti, all’epoca, era talmente dichiarata,
che essi stessi, benché fossero consapevoli di avere a volte realizzato
veri capolavori, almeno dal punto di vista estetico, evitavano
addirittura di firmare le proprie opere (forse per un senso di
ammissione nei confronti del loro inqualificabile comportamento?).
E’ il caso dell‘autore di cui appunto non si conosce il nome della
marmorea Colonna Traiana (110-113 dC.) fatta erigere da come si evince
dal nome, per onorare le imprese belliche, perpetrate da Traiano
Imperatore, ai danni dei Daci, in due momenti cruciali di quella lunga
campagna militare: 101 - 102 e il 105 - 107 dC.
La colonna alta oltre 30 m fu fatta sistemare a Roma nel Foro
(progettato verosimilmente, dal grande architetto, Apollodoro di
Damasco), per celebrare le gesta, dell’Imperatore in questione.
Eretta, nel luogo del suo sepolcro, era circondata dalle due
biblioteche, greca e latina, dalle quali era più facile osservare ed
ammirare le immagini realizzate sulla còclide.
Alla sua sommità svetta oggi la statua di San Pietro che ha sostituito
quella dell’Imperatore (ciò ha garantito la salvezza della colonna, che
altrimenti come spesso avveniva sarebbe stata distrutta) all’indomani
del sopravvento al potere della cristianità sul mondo pagano.
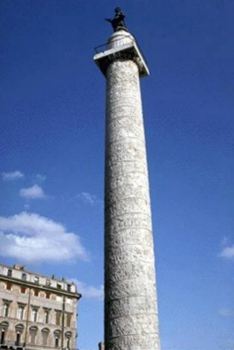
Ma quel che più
esteticamente affascina della colonna è il suo fregio, che si dipana in
forma di spirale (còclide appunto), lungo il suo fusto per circa 200
metri.
Per determinare un effetto di più marcato realismo prospettico e di
bilanciamento complessivo delle scene, l’artista ha studiato le
dimensioni delle diverse fasce, facendole variare a partire dal basso da
60 a 80 cm.

Qui sono
raccontate minuziosamente, come in un “fumetto” (ma forse sarebbe meglio
dire, documentaristicamente), avvolgente, gli avvenimenti, con il punto
di vista dell’anonimo autore dell’opera, denominato, Maestro di Traiano,
il quale “ovviamente” come premesso, racconta gli avvenimenti,
parteggiando per la committenza Imperiale.
Ed è questo modo di raccontare le cose, che ce le lascia paragonare a
certi servizi televisivi “patinati”, asserviti al potere costituito, che
ci descrivono le guerre come quella che attualmente si sta svolgendo in
Iraq, da un unico punto di vista, quello di una parte dell’occidente
cattolico-protestante, che intende dare la caccia al nemico mussulmano,
reo di possedere una cultura “altra”, che “dev’essere assolutamente
dominata”.
Sul piano stilistico l’anonimo “Maestro di Traiano”, ha utilizzato, in
quest’opera, la tecnica del bassorilievo, incidendo la pietra con un
rilievo molto basso, in taluni casi effettuando una leggera incisione,
così da far assomigliare l’Opera ad un dipinto.

La storia che si
svolge con ritmo incalzante e senza interruzioni, si “legge”
cronologicamente dal basso verso l’alto; come ci riferisce lo storico
dell’arte, Francesco Abbate: “non più semplice cronaca, ma commossa
epopea.
Con una tensione drammatica che quasi mai si allenta sono raffigurate le
battaglie, le marce faticose, il passaggio dei fiumi, l’assalto alle
città, i boschi e le pianure, le fortificazioni e gli accampamenti e
nella disperazione dei vinti, nella sofferenza dei feriti, nel dramma
dei prigionieri si fa strada un sentimento nuovo di umana pietà.”
A partire dalla parte inferiore della colonna vi è l’insediamento Romano
in terra Dacia (l’attuale Romania), che si traduce nella realizzazione
di un complesso sistema di fortificazione, secondo naturalmente lo stile
e la tecnica ingegneristica, della Roma imperiale.
Verso la sommità della colonna, luogo in cui ormai il “film” volge al
termine, assistiamo alla scena del suicidio di Decèbalo, re dei Daci.
Ormai irrimediabilmente braccato ed accerchiato all’interno della
boscaglia dai soldati Romani si dà eroicamente alla morte, volgendo il
fiero sguardo al nemico, uccidendosi prima di poter cadere vivo nelle
altrui mani.
La storia termina enfaticamente, come descrivono i libri di scuola sui
quali si dice che il “Maestro di Traiano” rappresenta i romani che
rendono onore alla grandezza morale del nemico vinto, esaltando le loro
virtù come popolo capace di rispetto ed ammirazione anche per il
comportamento dignitoso e coraggioso di un re barbaro.
Anche questo finale ci sembra quello di un film che molto probabilmente
vedremo prossimamente su vera pellicola cinematografica, anzi, su CD e
DVD anziché su marmo, e come sempre accade anche questa volta chi
scriverà la narrazione dei fatti saranno ancora i vincitori ma… sarà
proprio quella la verità?
|
