Walter Benjamin e l’angelo della morte
di Silvia Golfera
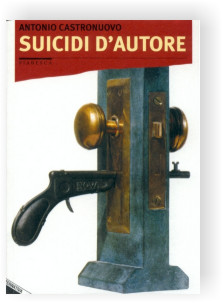
“Oggi, al cimitero di
Port Bou si sale per un breve tratto di strada fra basse palazzine. Il
cimitero si affaccia su un’azzurra insenatura che promette dolcezza e
invita a tuffarsi dall’alto” scrive Antonio Castronuovo, descrivendo il
luogo dove riposa il filosofo tedesco Walter Benjamin, di cui narra la
difficile vicenda esistenziale e l’ancor più tragico epilogo, in un
capitolo di “Suicidi di autore”. Libro affascinante che ripercorre la
vicenda terrena di alcuni artisti ed intellettuali del ’900 che hanno
scelto di suggellare la propria esistenza con un gesto estremo.
Castronuovo tenta non di penetrare, ma di approssimarsi al mistero di
quella scelta che getta comunque una luce obliqua e screziata sulla vita
di chi la compie. “Il lato oscuro della storia ha una superficie
infinita” osserva, arrestandosi in prossimità dell’enigma.
Libro dai mille spunti, eppure, chissà per quale insondabile ragione,
ciò che mi resta più attaccato è il respiro dei luoghi in cui si
svolgono le vicende. “L’estate è così bella, le campagne attorno a
Nagybanya sono fertili e sfolgorano di magnifici colori” scrive, per
esempio, a proposito dei luoghi che assistettero alla morte di Irma
Seidler, pittrice ungherese. Oppure ancora, ecco l’izba in cui Marina
Cvetaeva, poetessa russa inghiottita nella trappola staliniana, trova
rifugio dopo essere stata sfollata da Mosca: “una stanza chiusa da una
tenda che non giungeva al soffitto…Sulle assi, spaccate dal caldo,
ronzavano grosse mosche verdi”. L’importanza dei luoghi. Le banalità del
quotidiano che danno colore, profumo e vita all’esistenza, anche a
quella più eccezionale.
Ho sempre pensato che non si possa capire a fondo un autore, un artista,
se non sono entrati anche nei nostri occhi i paesaggi che ha respirato.
Ce ne rendiamo conto vivendo: quanto la facciata di una casa, una
strada, lo scorcio di una piazza, una particolare luminescenza del
cielo, imprimono una piega particolare ai nostri pensieri, al nostro
sentire.
Ma è su Walter Benjamin, uno dei quindici personaggi raccontati nel
libro, che voglio soffermarmi. Castronuovo ne ricostruisce le ultime
ore. Quel tentativo di fuga di un uomo già molto stanco, avvilito, che
ama la stanzialità e le lunghe ore trascorse in biblioteca, eppure è
costretto ad un nomadismo incessante. Non solo dalla sua condizione di
esule dalla Germania nazista, ma anche da quella di ebreo che patisce
doppiamente la crisi d’identità che travolge la società europea e che
stenta quindi a trovare in essa una collocazione certa. Un nomadismo che
si fa condizione esistenziale, capacità di smarrirsi nel mondo, così
come nell’incipit di “Infanzia Berlinese” parla della capacità di
smarrirsi dentro la città come in una foresta. E la morte in tasca, che
continua a tentarlo. Questo riesce a far rivivere il nostro autore,
spruzzando qua e là qualche frammento della vita dello sfortunato
tedesco, per meglio illuminare il sapore del gesto. Come un affresco
dove pochi, intensi particolari, suggeriscono la figura completa.
L’ultimo atto di questa “fuga senza fine” è il tentativo di traghettarsi
fuori dall’Europa in fiamme, ormai attanagliata nella morsa hitleriana,
inferno dal quale Benjamin aveva tuttavia stentato ad allontanarsi.
Fuoriuscito dalla Germania poco dopo l’avvento del nazismo, si era
rifugiato in Francia, a Parigi, dove “aveva eletto la Bibliothèque
Nazionale a sterminato cantiere di ricerca. Viveva in precarie
condizioni economiche…Aveva perso la cittadinanza tedesca con ordinanza
del luglio 1939: quando perciò nel settembre dello stesso anno la
Germania invase la Polonia, Benjamin fu internato come apolide di
origine tedesca…Liberato dopo due mesi per l’intervento di amici
influenti rientrò a Parigi, ma scrisse in una lettera che <<il numero di
coloro che si sentono a proprio agio in questo mondo si va riducendo
sempre più>>”(op.cit.).
A proprio agio nel mondo che conosceva non s’era sentito mai, e pure
l’infatuazione per la Russia dei Soviet aveva avuto vita breve. Ma
tuttavia non nutriva accese illusioni su ciò che poteva attenderlo
altrove. Grazie all’amico Gershom Scholem, il grande studioso di mistica
ebraica, la Kabbalah, che già dal 1923 viveva a Gerusalemme, si era
attivato per ottenere un incarico accademico presso la nuova università
ebraica. Scholem, prevedendo il disastro che si stava profilando, lo
invitava a raggiungerlo. Benjamin rispondeva che stava sì studiando
l’ebraico di cui portava sempre con sé la grammatica, ma poi rimandava
costantemente la partenza, finendo col restare intrappolato
nell’invasione tedesca della Francia. Del resto immaginarlo, lui figlio
della più raffinata cultura europea, nella vita rude e un po’ primitiva
della Palestina di allora, non è facile. In effetti non furono molti i
tedeschi che vi emigrarono, né furono sempre bene accolti. In Palestina
li chiamavano yekke, parola dall’etimologia incerta che insieme
significa ‘bellimbusto, clown, ebreo dalla testa dura’, certamente
un’offesa. Uno yekke famoso, Arnold Zewig, così si lagnava in una
lettera a Freud: “…Il funzionamento scricchiolante della macchina della
civilizzazione è il problema principale in questo paese. Noi non siamo
disposti ad abbandonare i nostri standard di vita e il paese non è
disposto a soddisfarli. E poiché gli ebrei di Palestina sono giustamente
fieri di quanto già esiste e noi giustamente irritati per tutto ciò che
ancora manca, c’è un tacito attrito.” (da Tom Segev “Il settimo milione”
Mondadori)
Gli Stati Uniti dovevano apparire un approdo migliore a Benjamin, che
ottenne un visto d’ingresso in quel paese, ma non un permesso per
lasciare la Francia. Castronuovo ci racconta come ciò avvenne grazie
all’interessamento di Juliane Favez, responsabile della succursale
svizzera dell’Istituto Horkheimer.
Vado a sfogliare un vecchio libro di Mary Jayne Gold, “Marseille année
40”. Mary Jayne è una ricca americana che viaggia e studia nell’Europa
d’anteguerra. Allo scoppio del conflitto è ancora in Francia. Invece di
rientrare subito negli Stati Uniti si ferma a Marsiglia e collabora con
l’ambasciata ed altre istituzioni del suo paese per fare espatriare
quanta più gente possibile, ma soprattutto intellettuali, artisti,
persone influenti. Molti personaggi illustri passarono di lì, da Jean
Cocteau a Marc Chagall. Ritrovo fra le sue memorie alcune tracce di
Benjamin. Il suo nome, per esempio, compare fra quelli di una lista
segreta di persone da salvare, compilata dal Comitato di New York,
congiuntamente con l’American Federation of Labor e Il Museo di Arte
Moderna. Nella stessa lista sono segnati anche Franz Werfel, famosissimo
scrittore austriaco, e la moglie Alma, che in precedenti nozze aveva
sposato Gustav Malher, poi Gropius. Compaiono anche i nomi di Heinrich e
Golo Mann, rispettivamente fratello e figlio di Thomas.
Probabilmente Benjamin li ha incontrati. Fuggono infatti tutti da
Parigi, inseguiti dalle armate tedesche, in una situazione di panico
generale. Tutte le coste a Nord sono ormai presidiate fino alla
frontiera spagnola e l’unica salvezza è a Sud. Si ritrovano tutti a
Lourdes. Il nostro vi arriva il 15 giugno. I Werfel più o meno negli
stessi giorni, e prendono alloggio in una piccola stanza che Alma
paragona alla povera casa in cui Bernadette aveva trascorso la sua
infanzia. Fanno più volte visita alla grotta di Massabielle e lì Franz,
ebreo cristiano sempre tormentato fra sentimento di appartenenza alla
tradizione dei padri e desiderio di conversione, fa il voto di
raccontare la storia della Santa, se mai usciranno vivi da quell’incubo.
Anche loro, come il nostro, aspettano qui i documenti che li porteranno
in America, poi scenderanno a Marsiglia. È a Marsiglia che un altro
fuggitivo famoso, Arthur Koestler, fornirà a Benjamin alcune pastiglie
di morfina, per ogni evenienza.
I Werfel riusciranno a passare la frontiera, quella terribile frontiera
che si chiuderà invece per Benjamin, e per un giorno soltanto. I
doganieri erano solitamente gentili con i fuoriusciti. Loro stessi, i
più, avevano combattuto per la repubblica spagnola. Ma il 26 settembre,
quando incontrarono il nostro, era da poco uscito un decreto che
impediva il transito agli apolidi. E che altro potevano essere gli ebrei
tedeschi negli anni di Hitler?
La strada per arrivare in Spagna è dura. La comitiva dei Werfel si
arrampica lungo un sentiero per le capre, scivoloso, tagliato a picco e
fiancheggiato da precipizi. Se a uno capita di scivolare lo si aggancia
con una corda. Ma alla frontiera nessun problema e tranquilli, dopo una
notte in albergo a Port Bou, il primo paese spagnolo, si dirigono alla
stazione, per proseguire il viaggio in treno. Quel treno su cui Benjanim
avrà disperato di poter mai salire.
Port Bou appariva saccheggiato dalle bombe, perché non era ancora stato
ricostruito dopo la guerra civile. Anche l’hotel ne era rimasto
danneggiato. Lo stesso, forse in cui si spegnerà Benjamin. I Werfel
proseguiranno in treno fino a Lisbona e poi da lì in nave per l’America.
Il New York Times del 14 ottobre 1940 porta la notizia del loro sbarco.
“ Gli scrittori in fuga dai nazisti sono arrivati. Franz Werfel,
Heinrich Mann con altri 15 scrittori sono sbarcati dal piroscafo greco
Nea Hellas, nella banchina n. 4, alle 9 del mattino…”
Allo stesso modo poteva andare la storia di Benjamin, che invece a Port
Bou terminò il suo viaggio, e lì riposa in qualche punto non
identificato di quel cimitero che apparve ad Hannah Arendt “….certamente
il posto più bello e fantastico che abbia visto nella mia vita” (op.cit.).
Castronuovo ci racconta che oggi un cippo di pietra è stato innalzato
alla sua memoria. Alla sua sommità, secondo l’usanza ebraica, i
visitatori collocano sassolini che cercano nel terriccio del cimitero.
Antonio Castronuovo
Suicidi d’autore
Stampa Alternativa,
2003